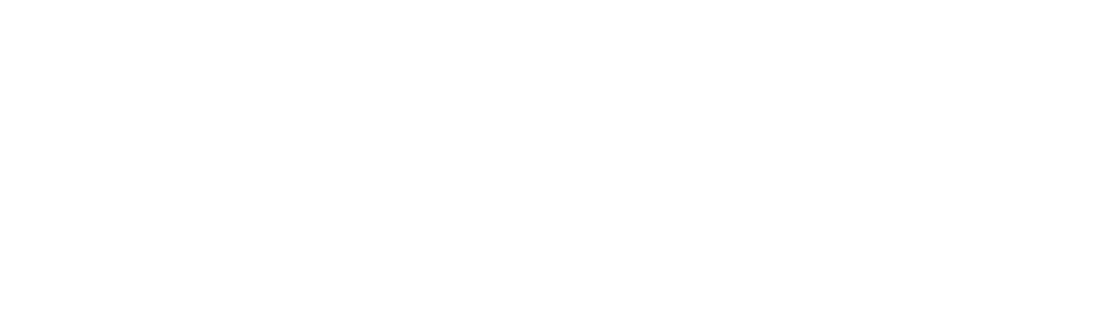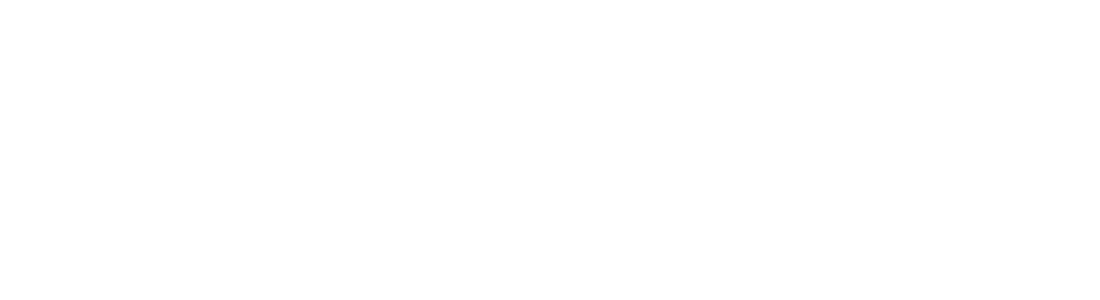Lungo via Badile, in Borgo Venezia, un alto muro di cinta custodisce, con gelosa riservatezza, il Cimitero della Comunità ebraica di Verona. Si tratta del quarto cimitero succedutosi a Verona in oltre sei secoli di presenza ebraica in città.
Del primo si hanno solo testimonianze documentali in un atto del 1435 che rimanda a un contratto di acquisto del 1390, da parte del banchiere Lazzaro di fu Samuele, di un terreno di Giacomo Pompei per la recinzione di un cimitero; il secondo, detto di Campo Fiore, attivo tra il secolo XVII e il secolo XVIII, si trovava tra via S. Francesco e via dell’Artigliere, sul sito dell’attuale Scuola Elementare Massalongo.
Il successivo, costituito dopo la saturazione di quello di Campo Fiore e utilizzato dal 1755 al 1855, era collocato nei pressi di Porta Nuova, sul sedime dell’attuale Camera di Commercio.
Nel 1855, sui terreni di un lascito della famiglia Forti, fu realizzato l’attuale quarto cimitero, che, progettato dall’ingegner Gemma, risultò per l’epoca estremamente innovativo rispetto ai contemporanei cimiteri in uso in Italia, e suscitò un dibattito a livello nazionale protrattosi nei decenni successivi. Per comprendere l’originalità dell’esemplare veronese, risulta allora necessario fare una riflessione sulle caratteristiche dei cimiteri ebraici italiani in uso fino alla metà dell’ottocento, e su come il tema della “emancipazione” post-unitaria, cioè del riconoscimento dell’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, senza distinzione di culto, abbia influito sui caratteri architettonici anche dei luoghi di sepoltura.
Fino alla metà dell’ottocento per gli ebrei della Diaspora il cimitero non era solo il luogo di una sepoltura privata, ma uno dei principali luoghi (insieme alla sinagoga) di identificazione comunitaria: seppellire il defunto significava confrontarsi con lo spazio della memoria non solo individuale ma soprattutto collettiva, significava non disperdere il comune patrimonio culturale. Per una società perennemente emarginata, segregata o espulsa, conservare il proprio patrimonio culturale diventava garanzia di sopravvivenza. Ancora, il cimitero ebraico si differenzia da quello delle altre grandi religioni monoteiste non solo per questa dimensione “culturale” ma anche per una motivazione “antropologica”, legata alla grande tradizione nomade del popolo ebraico: un popolo che attraversa l’Esodo non può permettersi di indulgere nel culto dei morti, la tomba deve essere in fretta abbandonata perché la tribù deve riprendere il viaggio. La memoria, allora, non può essere legata ad un luogo, ma viene affidata esclusivamente alle regole della ritualità funebre.
E sono proprio queste regole che danno vita ad un’originale grammatica dello spazio di sepoltura: la mancanza di culto dei morti che permette, peraltro, al popolo di Israele di differenziarsi dagli oppressori d’Egitto, i più esperti dell’antichità in culto dei morti, introduce la tendenza a lasciare incolti i cimiteri, quasi che la natura debba prendere il sopravvento (è viva l’immagine del cimitero di Venezia); il divieto di riesumazione delle salme, dettato dal rispetto sacrale per il corpo come emanazione dell’Altissimo, porta alla congestione delle sepolture e delle lapidi (come non ricordare il cimitero ebraico di Praga); la norma dell’inviolabilità della tomba come luogo di proprietà giuridica del defunto, oltre al precetto dell’uguaglianza degli uomini di fronte alla morte, impone la realizzazione di semplici lapidi con il nome a indicare l’area della sepoltura; e il sasso deposto sulle lapidi, a perenne ricordo delle frettolose sepolture nel deserto. La concretizzazione spaziale e formale dei precetti religiosi ebraici ha generato per secoli la specificità di questi luoghi.
Tutto questo fino all’Unità d’Italia, al riconoscimento della libertà di culto e all’integrazione delle comunità ebraiche nel tessuto sociale italiano. Dopo la proclamazione del Regno, gli ebrei italiani sono travolti dall’euforia per una nuova libertà di espressione (anche artistica e architettonica) fino ad allora inimmaginabile, e cercano di esprimersi attraverso un’estetica che sia loro propria: ma non per questo la trovano. “Uno stile veramente giudaico che io mi sappia non esiste” riconosce Marco Treves, il più dotato degli architetti italiani di origine israelita. Nelle architetture per il culto e per la sepoltura si sperimenta allora un eclettismo di elementi assiro-babilonesi ed egizi, un riferimento all’architettura greca e romana, ma anche a quella moresca, un “incredibile pasticcio”, come ebbe a definirlo Giorgio Bassani nella descrizione della tomba Finzi-Contini, che ha come unico scopo quello di far emergere dal buio di secoli di discriminazione la propria storia e avviare la popolazione israelita ad un lento processo di integrazione. Tale processo deve passare necessariamente anche attraverso il “decoro” della coreografia funebre e cioè la modernizzazione delle strutture e degli spazi identitari, attraverso la “monumentalizzazione” dell’architettura, testimone dell’emancipazione in atto.
Come disse il rabbino Isacco Pardo nel discorso inaugurale della nuova sinagoga di Verona, “se vogliamo che la nostra religione sia rispettata, dobbiamo renderla rispettabile”.
In questo clima di modernizzazione si inserisce la costruzione del cimitero ebraico di Verona, che all’epoca fu celebrato da Lelio Della Torre sul «Corriere Israelitico» come “il primo cimitero israelitico italiano di cui l’arte e non il caso abbia tracciato i compartimenti, a cui abbia dato una forma regolare, un carattere, un’espressione”. Si tratta perciò del primo cimitero progettato secondo le nuove norme igienico sanitarie e il nuovo “decoro”, il primo che si interroga sull’assolutezza dei precetti religiosi e prova a mediarli con la nuova nascente etica borghese. Il cimitero risulta suddiviso in quattro campi di sepoltura riempiti ordinatamente in successione temporale, separati da un viale alberato e preceduti da un fabbricato ad usi vari (casa del custode e locali ad uso oratorio, ora dismesso), da una loggia e, di fronte all’ingresso, a chiusura del viale principale, da una cappella in stile neorinascimentale utilizzata per l’ufficio funebre, comprendente la camera mortuaria per il lavaggio rituale della salma. Lungo il viale principale e lungo il muro di cinta sono collocate le tombe delle personalità “benemerite”, o piuttosto delle persone “benestanti”, considerando il nuovo ceto borghese che si andava formando dove i due valori spesso coincidevano. Nei rimanenti campi di sepoltura, lapidi tutte uguali in schematica successione.
E si intuisce ancor più l’uso, in alcune tombe, di un apparato iconografico “alla moda” del momento, sia essa il classicismo di fine ottocento, o il liberty di inizio novecento: gli ebrei veronesi, come quelli italiani, premono per una modernizzazione della società italiana che li possa vedere finalmente protagonisti, e si affidano, pertanto, agli architetti più in voga del momento. A Verona, Ettore Fagiuoli, dopo il progetto per la Sinagoga, disegnerà per il cimitero ebraico due tombe di grande compostezza figurativa, la tomba Grassetti del 1920 (non realizzata) e la tomba Bassani, del 1921, il cui modello verrà ripreso in serie per tutte le sepolture del nucleo familiare come segno distintivo ed emblematico; ma non da meno sono quelle realizzate per la famiglia di Achille Forti da C. Spazzi nel 1925 o per la famiglia Cuzzeri da E. Girelli. Rimangono leggibili i precetti secolari dell’assenza di ritratti, della natura rigogliosa, dell’apparato iconografico con gli antichi simboli biblici, delle vasche per le abluzioni rituali, ma tutto risulta ordinato, controllato, lindo, “progettato” con il preciso intento di “assimilare” la popolazione ebraica alla società borghese contemporanea; al punto di decidere di esibire, forse per la prima volta in Italia, persino qualche inconsueta immagine fotografica del defunto.
E a testimonianza di questa grande fiducia nelle possibilità della popolazione di religione ebraica di vivere un futuro pacificato dalle persecuzioni millenarie e quindi di grande espansione, il cimitero prevedeva due campi di ampliamento di 9000 mq ciascuno, rispetto ad una ampiezza iniziale di 11.000 mq, dove sono oggi conservate, malamente affastellate, le bellissime lapidi settecentesche provenienti da Campofiore.
Il cimitero di Verona risulta, quindi, la testimonianza più avanzata del processo di “assimilazione” postunitaria che ha investito la popolazione italiana di religione ebraica. E mai come a Verona il termine “assimilazione” diviene equivoco e fortemente allusivo. Equivoco, perché l’espressione fa riferimento alla sopravvivenza stessa della vita spirituale e religiosa ebraica, che rischia di diluirsi fino al suo totale “scioglimento” nel completo e definitivo processo di integrazione sociale; ed allusivo, perché sottintende una sostanziale sudditanza al modello (borghese) di riferimento. Dopo il 1945, anche (ma non solo) a causa della Shoah, in molte Comunità di dimensioni medio-piccole, come quella di Verona, cambia profondamente il quadro ambientale in cui la Comunità si era sviluppata, determinando un profondo e irrimediabile ridimensionamento. Questa situazione determina, per decenni, uno stato di degrado di gran parte dei cimiteri, tendenza che solo negli ultimi anni si è interrotta attraverso progetti di recupero e strategie di valorizzazione volte a rendere maggiormente conoscibile questo importante patrimonio architettonico proprio dell’identità ebraica e italiana. •