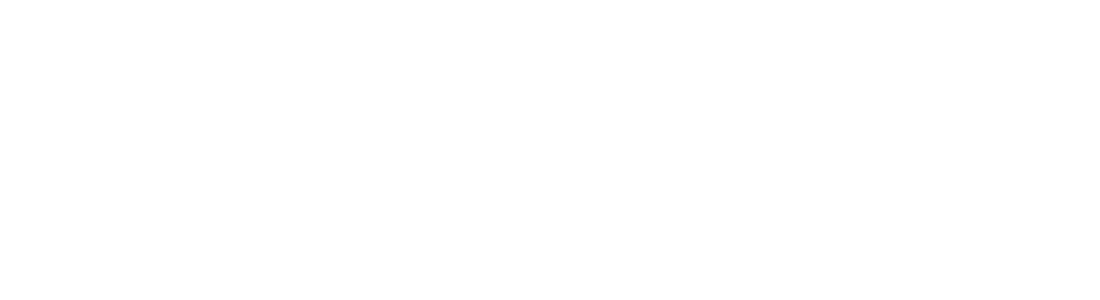RESISTENZA – Gli ebrei che liberarono l’Italia, l’ultimo capitolo della ricerca del CDEC
Il progetto ha scandagliato migliaia di fonti, documenti, archivi pubblici e privati, a partire da quelli del Cdec e dell’Archivio Centrale dello Stato, ma anche memorie personali, lettere, testimonianze. I dati sono oggi consultabili sul sito resistentiebrei.cdec.it, dove sono raccolti 815 profili biografici, corredati da informazioni anagrafiche, storiche, e in alcuni casi podcast e mostre digitali. «È un lavoro certosino e continuo a scoprire nomi nuovi. Leggo qualsiasi cosa riguardi la Resistenza, e appena un cognome cattura la mia attenzione, controllo. L’ultimo caso è di questi giorni, quando ho trovato Paolo Adler di Torino, indicato dai censimenti fascisti come ebreo».Il partigiano Gianfranco Sarfatti
Tra le storie che emergono nell’ultima fase della ricerca, quella di Gianfranco Sarfatti colpisce per la coerenza e la lucidità delle scelte, sottolinea la storica. Nato a Firenze nel 1922, venne espulso da scuola a soli sedici anni a causa delle leggi razziali. Continuò gli studi da privatista, mentre già si occupava di assistere i profughi ebrei stranieri. Nel 1943, dopo la caduta del fascismo, si iscrisse all’università e si avvicinò al partito comunista. L’8 settembre passò alla clandestinità nel Fronte della Gioventù, l’organizzazione di giovani impegnati nella Resistenza ideata dal triestino Eugenio Curiel, fisico ebreo, a cui sarà riconosciuta la medaglia d’oro al valor militare. Dopo una retata a Firenze nel febbraio del 1944, Sarfatti fu tra i pochi del suo gruppo a non essere arrestato. Seguì il consiglio del partito e si rifugiò in Svizzera con i genitori, aiutato da Tina Lorenzoni, staffetta partigiana, che morirà poco dopo nella liberazione di Firenze.
A Losanna fu ammesso alla facoltà di ingegneria e si unì all’associazione Corda Fratres, continuando a organizzare attività politiche tra gli studenti. Nell’agosto dello stesso anno, spinto dal desiderio di combattere per la liberazione dal nazifascismo, decise di tornare in Italia con un gruppo di volontari. A Cogne, in Val d’Aosta, fondò un giornale partigiano e prese il nome di battaglia Gaddo, in omaggio al fratello emigrato nella Palestina mandataria. Nei mesi successivi assunse il ruolo di commissario politico nella banda partigiana La Suelvaz. Durante l’inverno, il gruppo si rifugiò alla Morgnetta di Fenis, in alta quota, dove resistette a condizioni proibitive. Il 21 febbraio 1945, un’imboscata italo-tedesca sorprese la formazione. Alcuni riuscirono a fuggire, ma Gaddo, ferito, rimase con tre compagni. Furono tutti catturati e uccisi.
Il libro in cantiere
Oggi la sua storia, come quella di molti altri, è restituita alla memoria collettiva grazie al lavoro della Fondazione Cdec. Martedì 29 aprile, alle 18.30, presso il Memoriale della Shoah di Milano, Picciotto presenterà pubblicamente questa ultima fase della ricerca, in dialogo con il giornalista Wlodek Goldkorn. In occasione del 25 aprile si potranno scoprire cinque nuove storie di partigiani ebrei – Gilberto Coen, Bruno Dell’Arriccia, Enrico Lowenthal, Adolfo Perugia e Franco Valabrega – raccontante in un podcast con la voce di Elia Schilton.
«Questa fase del lavoro si conclude, ma la ricerca non è affatto finita. Continueremo a lavorare: in cantiere ora c’è un libro che potrà ospitare tutte le riflessioni che sul sito non trovavano spazio, per restituire le complessità delle identità, delle scelte e delle vite che abbiamo incontrato» conclude Picciotto.
Daniel Reichel