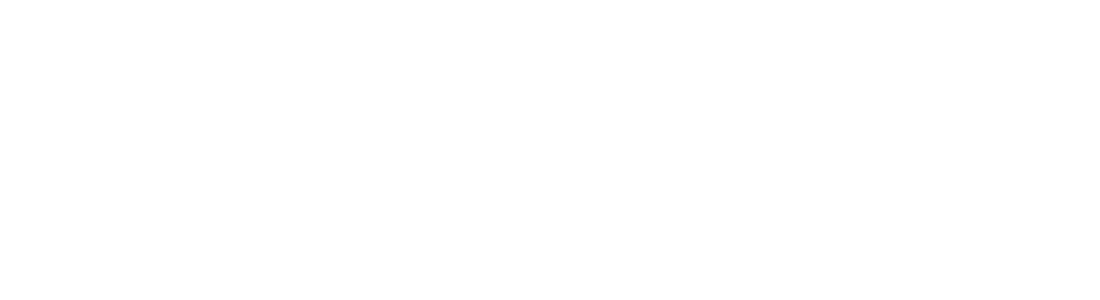Perché noi sacrifichiamo? – Parashat Vayikra
di Rabbino Lord Jonathan Sacks zt”l
Tradotto ed adattato da David Malamut
Vayikra, il terzo libro della Torah, è notevolmente diverso dagli altri. Non contiene alcun viaggio. È ambientato interamente sul Sinai. Occupa solo una breve porzione di tempo: un singolo mese. Non c’è quasi nessuna narrazione. Eppure, ambientato al centro dei libri mosaici, è la chiave per comprendere la vocazione di Israele come “regno di sacerdoti e nazione santa“, la prima dichiarazione di missione collettiva della storia.
Questa parsha, con cui si apre il libro, descrive i vari tipi di sacrificio che gli Israeliti portavano al Tabernacolo. Ce n’erano cinque: l’olocausto (ola), l’offerta di cereali (minchah), l’offerta di pace (shelamim), l’offerta per il peccato (chatat) e l’offerta per la colpa (asham).
Le leggi dei sacrifici che dominano i primi capitoli del Libro del Levitico sono tra le più difficili da comprendere nella Torah al giorno d’oggi. Sono passati quasi duemila anni da quando il Tempio fu distrutto e il sistema sacrificale giunse al termine. Ma i pensatori ebrei, soprattutto i più mistici tra loro, si sforzarono di comprendere il significato profondo dei sacrifici e l’affermazione che facevano sulla relazione tra l’umanità e Dio. Furono così in grado di salvare il loro spirito anche se la loro attuazione fisica non era più possibile. Tra i più semplici ma più profondi c’era il commento fatto dal rabbino Shneur Zalman di Liadi, il primo Rebbe di Lubavitch. Notò una stranezza grammaticale nella seconda riga di questa Parsha:
<<Parla ai figli d’Israele e dì loro: Quando alcuno tra voi voglia offrire un sacrifizio al Signore, tra gli animali quadrupedi potrete fare il vostro sacrifizio della specie bovina e della pecorina (o caprina)>> (Levitico 1, 2)
O almeno così si leggerebbe il versetto se fosse costruito secondo le normali regole grammaticali. Tuttavia, l’ordine delle parole della frase in ebraico è strano e inaspettato. Ci aspetteremmo di leggere: adam mikem ki yakriv, “quando uno di voi offre un sacrificio”. Invece, ciò che dice è adam ki yakriv mikem, “quando uno offre un sacrificio di voi“.
L’essenza del sacrificio, ha detto il rabbino Shneur Zalman, è che offriamo noi stessi. Portiamo a Dio le nostre facoltà, le nostre energie, i nostri pensieri ed emozioni. La forma fisica del sacrificio, un animale offerto sull’altare, è solo una manifestazione esterna di un atto interiore. Il vero sacrificio è mikem, “di voi”. Diamo a Dio qualcosa di noi stessi. (Rabbi Shneur Zalman of Liadi, Likkutei Torah, Vayikra 2aff.)
Cosa diamo esattamente a Dio quando offriamo un sacrificio? Nel misticismo ebraico, tra cui il rabbino Shneur Zalman, hanno parlato di due anime che ognuno di noi ha dentro di sé: l’anima animale (nefesh habeheimit) e l’anima divina. Da un lato siamo esseri fisici. Siamo parte della natura. Abbiamo bisogni fisici: cibo, bevande, riparo. Nasciamo, viviamo, moriamo. Come dice l’Ecclesiaste:
<<Il destino dell’uomo è come quello degli animali; lo stesso destino attende entrambi: come muore uno, così muore l’altro. Entrambi hanno lo stesso respiro; l’uomo non ha alcun vantaggio sull’animale. Tutto è un mero respiro fugace. >> (Ecclesiaste 3, 19)
Eppure, non siamo semplicemente animali. Abbiamo dentro di noi desideri immortali. Possiamo pensare, parlare e comunicare. Possiamo, tramite atti di parola e ascolto, raggiungere gli altri. Siamo l’unica forma di vita a noi nota nell’universo che può porre la domanda “perché?“. Possiamo formulare idee ed essere mossi da alti ideali. Non siamo governati solo da pulsioni biologiche. Il Salmo 8 è un inno di meraviglia su questo tema:
“Quando io veggo i tuoi cieli che sono opera delle tue dita;
la luna e le stelle che tu hai disposte;
Io dico: che cosa è l’uomo, che tu ne abbi memoria? E che cos’è il figliuolo dell’uomo, che tu ne prenda cura?
E che tu l’abbi fatto poco minor degli Angeli, e l’abbi coronato di gloria e d’onore?
E che tu lo faccia signoreggiare sopra l’opere delle tue mani e abbi posta ogni cosa sotto i suoi piedi?” (Salmo 8, 4-7)
Fisicamente, non siamo quasi nulla. Spiritualmente, siamo sfiorati dalle ali dell’eternità. Abbiamo un’anima divina. La natura del sacrificio, intesa psicologicamente, è quindi chiara. Ciò che offriamo a Dio è (non solo un animale, ma) il nefesh habeheimit, l’anima animale dentro di noi.
Come funziona questo in dettaglio? Un suggerimento è dato dai tre tipi di animali menzionati nel versetto nella seconda riga di Parshat Vayikra (vedi Levitico 1, 2): beheimah (animale), bakar (bestiame) e tzon (gregge). Ognuno rappresenta una caratteristica animalesca separata della personalità umana.
Beheimah rappresenta l’istinto animale stesso. La parola si riferisce agli animali domestici. Non implica gli istinti selvaggi del predatore. Ciò che significa è qualcosa di più mansueto. Gli animali trascorrono il loro tempo alla ricerca di cibo. Le loro vite sono limitate dalla lotta per sopravvivere. Sacrificare l’animale dentro di noi significa essere mossi da qualcosa di più della semplice sopravvivenza.
Wittgenstein, quando gli fu chiesto quale fosse il compito della filosofia, rispose: “Mostrare alla mosca la via d’uscita dalla bottiglia delle mosche”.( Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations). La mosca, intrappolata nella bottiglia, sbatte la testa contro il vetro, cercando di trovare una via d’uscita. L’unica cosa che non riesce a fare è guardare in alto. L’anima divina dentro di noi è la forza che ci fa guardare in alto, oltre il mondo fisico, oltre la mera sopravvivenza, alla ricerca di un significato, uno scopo, un obiettivo.
La parola ebraica bakar, bestiame, ci ricorda la parola boker, alba, letteralmente “sfondare”, come i primi raggi di sole che squarciano l’oscurità della notte. Il bestiame, in fuga precipitosa, sfonda le barriere. A meno che non sia vincolato da recinti, il bestiame non rispetta i confini. Sacrificare il bakar significa imparare a riconoscere e rispettare i confini: tra sacro e profano, puro e impuro, permesso e proibito. Le barriere della mente possono a volte essere più forti dei muri.
Infine, la parola tzon, gregge, rappresenta l’istinto del gregge, la potente spinta a muoversi in una data direzione perché altri stanno facendo lo stesso (argomento presente in alcune opere: Charles Mackay, Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds; Gustave le Bon, The Crowd: A Study of the Popular Mind; Wilfred Trotter, Instincts of the Herd in Peace and War; ed Elias Canetti, Crowds and Power). Le grandi figure dell’ebraismo, Abramo, Mosè, i Profeti, si distinguevano proprio per la loro capacità di distinguersi dal gregge, di essere diversi, di sfidare gli idoli dell’epoca, di rifiutarsi di capitolare alle mode intellettuali del momento. Questo, in ultima analisi, è il significato della santità nell’Ebraismo. Kadosh, il sacro, è qualcosa di separato, diverso, separato, distintivo. Gli ebrei sono stati l’unica minoranza nella storia a rifiutarsi costantemente di assimilarsi alla cultura dominante o di convertirsi alla fede dominante.
Il sostantivo korban, “sacrificio”, e il verbo lehakriv, “offrire qualcosa in sacrificio”, in realtà significano “ciò che è portato vicino” e “l’atto di portare vicino”. L’elemento chiave non è tanto rinunciare a qualcosa (il significato usuale di sacrificio), quanto piuttosto portare qualcosa vicino a Dio. Lehakriv consiste nel far sì che l’elemento animale dentro di noi venga trasformato attraverso il fuoco divino che un tempo ardeva sull’altare e che ancora arde nel cuore della preghiera, se cerchiamo veramente la vicinanza a Dio.
Per una delle ironie della storia, questa antica idea è diventata improvvisamente contemporanea. Il darwinismo, la decodificazione del genoma umano e il materialismo scientifico (l’idea che il materiale sia tutto ciò che esiste) hanno portato alla conclusione diffusa che siamo tutti animali, niente di più, niente di meno. Condividiamo il 98 percento dei nostri geni con i primati. Siamo, come diceva Desmond Morris, “la scimmia nuda” (Desmond Morris, The Naked Ape). Secondo questa visione, l’Homo sapiens esiste per puro caso. Siamo il risultato di una serie casuale di mutazioni genetiche e ci capita di essere più adatti alla sopravvivenza rispetto ad altre specie. Il nefesh habeheimit, l’anima animale, è tutto ciò che esiste.
La confutazione di questa idea, ed è sicuramente tra le più riduttive mai sostenute da menti intelligenti, risiede nell’atto stesso del sacrificio come lo hanno inteso i mistici. Possiamo reindirizzare i nostri istinti animali. Possiamo elevarci al di sopra della mera sopravvivenza. Siamo capaci di onorare i confini. Possiamo uscire dal nostro ambiente. Come ha affermato il neuroscienziato di Harvard Steven Pinker: “La natura non detta cosa dovremmo accettare o come dovremmo vivere”, aggiungendo, “e se ai miei geni non piace, possono andare a buttarsi nel lago” (Steven Pinker, How the Mind Works). Oppure, come disse maestosamente Katharine Hepburn a Humphrey Bogart nel film La regina d’Africa, “La natura, signor Allnut, è ciò per cui siamo stati messi sulla terra per elevarci”.
Possiamo trascendere il beheimah, il bakar e lo tzon. Nessun animale è capace di autotrasformazione, ma noi sì. Poesia, musica, amore, meraviglia, le cose che non hanno alcun valore di sopravvivenza ma che parlano al nostro senso più profondo dell’essere, ci dicono tutte che non siamo semplici animali, assemblaggi di geni egoisti. Portando ciò che è animale dentro di noi vicino a Dio, permettiamo al materiale di essere intriso di spirituale e diventiamo qualcos’altro: non più schiavi della natura ma servitori del Dio vivente.