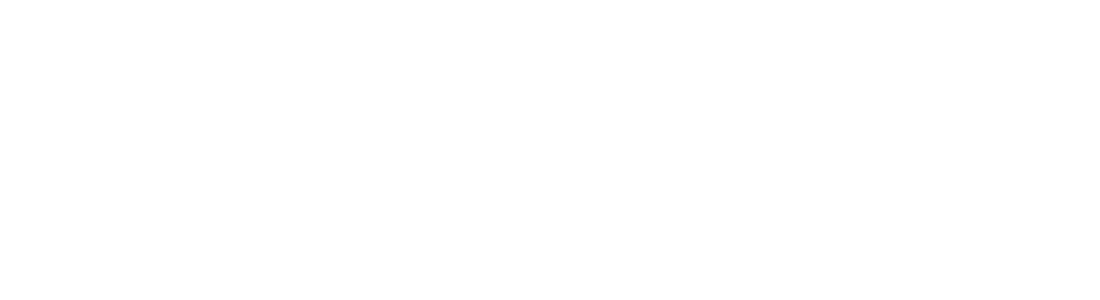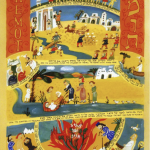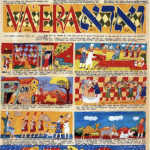Libertà e Verità , Parashat Va’era
di Rabbino Lord Jonathan Sacks zt”l
tradotto ed adattato da David Malamut
Perché Mosè disse al Faraone, se non proprio una bugia, almeno non la piena verità? Ecco la conversazione tra lui e il Faraone dopo la quarta piaga, arov, “il miscuglio (di belve, o d’insetti)”
<<Ed il Signore effettuò la parola di Mosè, ed il miscuglio cessò da Faraone, dai suoi servi, e dal suo popolo; non rimase di quelli (animali) pur uno. Ma Faraone ostinò il suo cuore anche questa volta, e non lasciò andare il popolo.>> (Esodo 8, 27-28)
Non solo qui ma ovunque, Mosè fa sembrare che tutto ciò che chiede è il permesso al popolo di intraprendere un viaggio di tre giorni, di offrire sacrifici a Dio e poi (implicitamente) di tornare in Egitto. Quindi, nella loro prima apparizione davanti al Faraone, Mosè e Aronne dicono:
<<E digli: Il Signore, Iddio degli Ebrei,mi mandò a te, per dirti: lascia andare il mio popolo a prestarmi culto nel deserto;“>> (Esodo 7, 16).
Il Faraone disse: “Chi è il Signore perché dovrei obbedirgli e lasciare andare Israele? Non conosco il Signore e non lascerò partire Israele”.
<<Indi Mosè ed Aronne andarono, e dissero a Faraone: Dice così il Signore, Iddio d’Israel: Lascia ch’il mio popolo vada a celebrarmi una festa nel deserto. Faraone disse: Chi è egli il Signore, ch’io abbia ad ubbidirgli di lasciar andare Israel? Non conosco il Signore, nè voglio lasciar andare Israel. Ed eglino dissero: Il Dio degli Ebrei si è a noi manifestato. Permetti deh! che andiamo nel deserto a una distanza di tre giornate di cammino, e facciamo sacrifizi al Signore nostro Dio, affinch’egli non ci assalga colla peste, o colla spada.>> (Esodo 5, 1-3)
Dio lo specifica addirittura prima che la missione abbia inizio, dicendo a Mosè presso il roveto ardente: “Eglino ti presteranno ascolto, quindi tu e gli anziani d’Israel vi recherete al re d’Egitto e gli direte: Il Signore, Iddio degli Ebrei, si è a noi manifestato. Or dunque permetti deh! che andiamo nel deserto, a una distanza di tre giornate di cammino, e facciamo sacrifizi al Signore, Iddio nostro” (Esodo 3, 18).
L’effetto “ingannevole” rimane fino alla fine. Dopo che gli Israeliti se ne sono andati, leggiamo:
<<Fu narrato al re d’Egitto, ch’il popolo era fuggito [cioè che non pensava a celebrare una festa, e poscia ritornare], e la mente di Faraone e de’ suoi servi si rivolse al popolo; e dissero: Che mai abbiamo fatto, lasciando andare Israel dal servirci?>> (Esodo 14, 5)
In nessun momento Mosè dice esplicitamente che si sta proponendo al popolo un permesso di andarsene permanentemente, e di non tornare mai più. Parla di un viaggio di tre giorni. C’è una discussione tra lui e il Faraone su chi deve andare. Solo i maschi adulti? Solo le persone, non il bestiame? Mosè chiede costantemente il permesso di adorare Dio, in un luogo che non sia l’Egitto. Ma non parla di libertà né di Terra Promessa. Perché no? Perché crea, e non corregge, una falsa impressione? Perché non può dire apertamente cosa intende?
I commentatori offrono varie spiegazioni. Il rabbino Shmuel David Luzzatto (Italia, 1800-1865) afferma che era impossibile per Mosè dire la verità a un tiranno come il Faraone. Rabbi Yaakov Mecklenburg (Germania, 1785-1865, Ha-Ktav veha-Kabbalah) afferma che tecnicamente Mosè non disse una bugia. In effetti voleva dire che l’intento per le persone che fossero libere di fare un viaggio per adorare Dio, e non ha mai detto esplicitamente che sarebbero tornate.
L’Abarbanel (Lisbona 1437 – Venezia 1508) racconta che Dio disse deliberatamente a Mosè di fare una piccola richiesta, per dimostrare la crudeltà e l’indifferenza del Faraone verso i suoi schiavi. Tutto ciò che chiedevano era una breve tregua dalle loro fatiche per offrire sacrifici a Dio. Se avesse rifiutato, sarebbe stato davvero un tiranno. Rav Elhanan Samet (Iyyunim be-Parshot Ha-Shevua, Esodo, 189) cita un commentatore anonimo che dice semplicemente che questa era una guerra tra il Faraone e il popolo ebraico, e in guerra è permesso, anzi talvolta necessario, ingannare.
In realtà, però, i termini dell’incontro tra Mosè e il Faraone si inseriscono in uno schema più ampio che abbiamo già osservato nella Torah. Quando Giacobbe lascia la casa di Labano, con tutta la sua famiglia, leggiamo: “Giacobbe rubò [deluse] la mente dell’arameo Lavàn, non avendogli dichiarato che pensava d’andarsene.” (Genesi 31, 20). Labano protesta contro questo comportamento:
<<Lavàn disse a Giacobbe: Che mai facesti, deludendo la mia mente, e menando via le mie figlie quali prigioni di guerra? Perchè ti ritirasti di soppiatto, ed ingannandomi? mentre se m’avessi comunicato (il tuo pensiero), t’avrei accompagnato con festa, con canti, col timpano e coll’arpa.>> (Genesi 31, 26-27)
Giacobbe deve ancora una volta dire, nella migliore delle ipotesi, una mezza verità quando Esaù suggerisce di viaggiare insieme dopo la riunione dei fratelli: “Ed egli gli disse: Il mio signore sa, che i figliuoli sono teneri, ed io ho meco (anche) le femine del bestiame minuto e del bovino, in istato di allattanti. Se vengono spinte innanzi (anche) un solo giorno, tutto il bestiame minuto morrebbe. Passi deh! il mio signore avanti al suo servo, e ch’io mi conduca lentamente, secondo il passo del bestiame che mi precede, ed il passo dei fanciulli, sino a tanto ch’io giunga appo il mio signore, in Seìr.” (Genesi 33, 13-14). Questa, sebbene non sia propriamente una bugia, è una scusa diplomatica.
Quando i figli di Giacobbe stanno cercando di salvare la loro sorella Dina che è stata violentata e rapita da Sichem l’Eveo, “I figli di Giacobbe rispondendo a
Sichem ed a Hhamòr suo padre, parlarono con inganno, posciachè quegli aveva contaminata Dinà loro sorella.” (Genesi 34, 13) quando Sichem e suo padre hanno proposto che l’intera famiglia venisse a stabilirsi con loro, dicendo loro che avrebbero potuto farlo solo se tutti i maschi della città si fossero sottoposti alla circoncisione. Ciò che accadde successivamente lo conosciamo.
Prima ancora troviamo che per tre volte Abramo e Isacco, costretti a lasciare la casa a causa della carestia, devono fingere di essere i fratelli delle loro mogli e non i loro mariti perché temono che altrimenti verranno uccisi per poter prendere Sara o Rebecca nel l’harem del re (Genesi 12, Genesi 20, Genesi 26).
Questi sei episodi non possono essere del tutto casuali o coincidenti rispetto al racconto biblico nel suo insieme. L’implicazione sembra essere questa: al di fuori della terra promessa gli ebrei nell’era biblica sono in pericolo se dicono la verità. Corrono il rischio costante di essere uccisi o, nella migliore delle ipotesi, ridotti in schiavitù.
Perché? Perché sono impotenti in un’epoca di potere. Sono una piccola famiglia, nella migliore delle ipotesi una piccola nazione, in un’epoca di imperi. Devono usare il loro ingegno per sopravvivere. In generale non dicono bugie ma possono creare una falsa impressione. Non è così che dovrebbero essere le cose. Ma è così che erano prima che gli ebrei avessero la loro terra, il loro unico spazio difendibile. È così che le persone in situazioni impossibili sono costrette ad essere se vogliono esistere.
Nessuno dovrebbe essere costretto a vivere nella menzogna. Nell’ebraismo la verità è il sigillo di Dio e la precondizione essenziale della fiducia tra gli esseri umani. Ma quando il vostro popolo viene ridotto in schiavitù e i suoi figli maschi vengono assassinati, dovete liberarli con ogni mezzo possibile. Mosè, che aveva già visto che il suo primo incontro con il Faraone aveva peggiorato le cose per il suo popolo, dovendo ancora produrre la stessa quantità di mattoni ma ora dovevano anche raccogliere la propria paglia (Esodo 5, 6-8), non ha voluto rischiare di peggiorare le condizioni ulteriormente.
La Torah qui non giustifica l’inganno. Al contrario, sta condannando un sistema in cui dire la verità può mettere a rischio la vita, come accade ancora oggi in molte società tiranniche o totalitarie. L’ebraismo, come una religione di dissenso, domande e “discussioni per amore del cielo”, è una fede che valorizza l’onestà intellettuale e la veridicità morale sopra ogni cosa. Nel Libro dei Salmi leggiamo:
<<Chi salirà al Monte del Signore? e chi starà nel luogo suo santo? L’uomo innocente di mani, e puro di cuore; il qual non eleva l’animo a vanità, e non giura con frode.>> (Salmi 24, 3-4)
Malachia dice di chi parla in nome di Dio: “Ebbe in bocca insegnamento leale, e iniquità non si trovò sulle sue labbra; procedette con me con integrità e rettitudine, e molti convertì dal peccato” (Malachia 2, 6). Ogni Amidah (la porzione della preghiera eseguita solennemente in piedi e in silenzio, prima della conclusione di ogni servizio religioso di tefilah mattutino, pomeridiano o serale) termina con la preghiera: “Mio Dio, proteggi la mia lingua dal male e le mie labbra dal linguaggio ingannevole”.
Ciò che la Torah ci dice in questi sei racconti della Genesi e nel settimo presente nell’Esodo è la connessione tra libertà e verità. Dove c’è libertà può esserci verità. Diversamente, non è possibile. Una società in cui le persone sono costrette a non essere del tutto oneste semplicemente per sopravvivere e non provocare ulteriore oppressione non è il tipo di società che Dio vuole che creiamo.