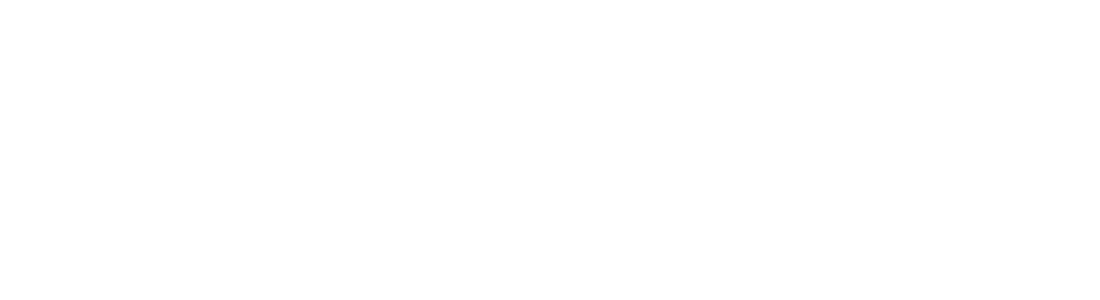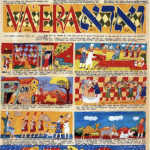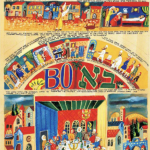La necessità di fare domande
di Rabbino Lord Jonathan Sacks zt”l
tradotto ed adattato da David Malamut
Non è un caso che Parshat Bo, la parte che tratta delle piaghe culminanti e dell’Esodo, si rivolga tre volte al tema dei figli e al dovere dei genitori di educarli.
Come ebrei crediamo che per difendere un Paese sia necessario un esercito, ma per difendere una civiltà sia necessaria l’istruzione. La libertà si perde quando viene data per scontata. A meno che i genitori non trasmettano i loro ricordi e i loro ideali alla generazione successiva, la storia di come hanno conquistato la libertà e le battaglie che hanno dovuto combattere lungo il percorso, il lungo viaggio vacilla e perdiamo la strada.
Ciò che è affascinante, però, è il modo in cui la Torah sottolinea il fatto che i bambini devono porre domande. Due dei tre passaggi della nostra Parsha parlano di questo:
<<E quando i vostri figliuoli vi diranno: Che cosa è questo rito che avete? Direte: È il sacrifizio della Pasqua [del trapasso], (in omaggio) al Signore, il quale trapassò oltre alle case dei figli d’Israel in Egitto, quando percosse gli Egizi, e le case nostre salvò. Il popolo [ciò udito] s’inchinò e prostrò.>> (Esodo 12, 26-27)
<<Ora, quando in avvenire tuo figlio t’interrogherà con dire: Che cosa è ciò? gli dirai: Con braccio forte il Signore ci trasse dall’Egitto, ov’eravamo schiavi.>> (Esodo 13, 14)
C’è un altro passaggio più avanti nella Torah che parla anch’esso di una domanda posta da un bambino:
<<Quando in avvenire tuo figlio t’interrogherà, con dire: Che cosa sono questi divieti, statuti e leggi, ch’il Signore, Iddio nostro, vi ha imposti? Dirai al tuo figlio: Noi fummo schiavi di Faraone in Egitto, ed il Signore ci trasse dall’Egitto con mano potente.>> (Deuteronomio 6, 20-21)
L’altro passaggio della Parsha di oggi, l’unico che non menziona una domanda, è:
<<E tu allora spiegherai la cosa a tuo figlio, con dire: (Ciò si fa) in grazia di quanto il Signore ha operato per me, quand’io sono uscito dall’Egitto.>> (Esodo 13, 8)
Questi quattro passaggi sono diventati famosi perché compaiono nell’ Haggadah di Pesach. Sono i quattro figli: uno saggio, uno malvagio o ribelle, uno semplice e “uno che non sa chiedere”. Leggendoli insieme, i Saggi giunsero alla conclusione che
- i bambini dovrebbero fare domande,
- il racconto di Pesach deve essere costruito in risposta alle domande poste dal bambino,
- è dovere di un genitore incoraggi i suoi figli a fare domande, e al bambino che non sa ancora come chiedere si dovrebbe insegnare a chiedere.
Non c’è assolutamente nulla di naturale in questo. Al contrario, va drammaticamente contro la tendenza della storia. La maggior parte delle culture tradizionali vede il compito di un genitore o di un insegnante istruire, guidare o comandare. Il compito del bambino è obbedire. “I bambini dovrebbero essere visti, non ascoltati”, recita un vecchio proverbio inglese. “Figli, siate obbedienti ai vostri genitori in ogni cosa, perché questo è gradito al Signore”, dice un famoso testo cristiano. Socrate, che trascorse la vita insegnando alla gente a fare domande, fu condannato dai cittadini di Atene per aver corrotto i giovani. Nel giudaismo avviene il contrario. È un dovere religioso insegnare ai nostri figli a fare domande. È così che crescono.
L’ebraismo è il fenomeno più raro: una fede fondata sul porsi domande, a volte profonde e difficili, che sembrano scuotere le fondamenta stesse della fede stessa. “Il giudice di tutta la terra non farà forse giustizia?” chiese Abramo. “Perché, Signore, perché hai causato difficoltà a questo popolo?” chiese Mosè. “Perché la via degli empi prospera? Perché tutti gli infedeli vivono a proprio agio?” chiese Geremia. Il libro di Giobbe è in gran parte costituito da domande, e la risposta di Dio consiste di quattro capitoli di domande ancora più profonde: “Dov’eri tu quando io gettavo le fondamenta della terra? … Riesci a catturare il Leviatano con un gancio? … Farà un accordo con te e ti permetterà di prenderlo come tuo schiavo per tutta la vita?”
Nella yeshivah, il riconoscimento più alto è porre una buona domanda: Du fregst a gutte kashe. Il rabbino Abraham Twersky, uno psichiatra profondamente religioso, racconta di come quando era giovane, il suo insegnante apprezzava le sfide alle sue argomentazioni. Nel suo inglese stentato, diceva: “Hai ragione! Hai ragione al 100%! Ora ti faccio vedere dove sbagli.“
A Isidor Isaac Rabi, vincitore del Premio Nobel per la fisica, una volta fu chiesto perché fosse diventato uno scienziato. Lui rispose: “Mia madre mi ha fatto diventare uno scienziato senza nemmeno saperlo. Tutti gli altri bambini tornavano da scuola e gli chiedevano: “Cosa hai imparato oggi?”. Ma mia madre era solita chiedere: “Izzy, hai fatto una bella domanda oggi?” Questo ha fatto la differenza. Fare buone domande mi ha reso uno scienziato.
Il giudaismo non è una religione di cieca obbedienza. Infatti, sorprendentemente, in una religione di 613 comandamenti, non esiste una parola ebraica che significhi “obbedire”. Quando l’ebraico venne ripreso come lingua viva nel diciannovesimo secolo, e ci fu bisogno di un verbo che significasse “obbedire”, dovette essere preso in prestito dall’aramaico: le-tsayet.
Invece di una parola che significa “obbedire”, la Torah usa il verbo shema, intraducibile in altra lingua perché significa
- ascoltare,
- udire,
- comprendere,
- interiorizzare e
- per rispondere.
Nella struttura stessa della coscienza ebraica è inscritta l’idea che il nostro dovere più alto è cercare di comprendere la volontà di Dio, non solo obbedire ciecamente.
Il verso di Alfred Tennyson, “Il loro modo di ragionare non è sul perché, ma il loro è fare o morire”, è quanto di più lontano possibile da una mentalità ebraica. Perché? Perché crediamo che l’intelligenza sia il dono più grande di Dio all’umanità. Rashi intende la frase secondo cui Dio ha creato l’uomo “a Sua immagine, a Sua somiglianza” nel senso che Dio ci ha dato la capacità di “comprendere e discernere”. La prima delle nostre richieste nell’ Amidah nei giorni feriali è per “conoscenza, comprensione e discernimento”. Una delle istituzioni rabbiniche più straordinariamente audaci fu quella di coniare una benedizione da pronunciare nel vedere un grande studioso non ebreo. Non solo vedevano la saggezza in culture diverse dalla loro, ma ne ringraziavano Dio. Quanto tutto ciò è lontano dalla ristrettezza mentale che così spesso ha avvilito e sminuito le religioni, passate e presenti.
Lo storico Paul Johnson una volta scrisse che l’ebraismo rabbinico era “un’antica e altamente efficiente macchina sociale per la produzione di intellettuali”. Molto di ciò ha avuto, ed ha tuttora, a che fare con la priorità assoluta che gli ebrei hanno sempre dato all’istruzione, alle scuole, al Beit Midrash, allo studio religioso come atto addirittura superiore alla preghiera, all’apprendimento come impegno che dura tutta la vita, e all’insegnamento come vocazione più alta della vita religiosa.
Ma molto ha a che fare anche con il modo in cui si studia e con il modo in cui insegniamo ai nostri figli. La Torah lo indica nel momento più potente e toccante della storia ebraica: proprio mentre gli Israeliti stanno per lasciare l’Egitto e iniziare la loro vita come popolo libero sotto la sovranità di Dio. Trasmettete il ricordo di questo momento ai vostri figli, dice Mosè. Ma non farlo in modo autoritario. Incoraggia i tuoi figli a chiedere, interrogare, sondare, indagare, analizzare, esplorare. Libertà significa libertà della mente, non solo del corpo. Coloro che hanno fiducia nella propria fede non devono temere alcuna domanda. Solo chi non ha fiducia, chi ha dubbi segreti e repressi, ha paura.
L’essenziale, però, è sapere e insegnare ai nostri figli che non tutte le domande hanno una risposta immediatamente comprensibile. Ci sono idee che comprenderemo pienamente solo con l’età e l’esperienza, altre che richiedono una grande preparazione intellettuale, altre ancora che potrebbero andare oltre la nostra comprensione collettiva in questa fase della ricerca umana. Darwin non ha mai saputo cosa fosse un gene. Anche il grande Newton, fondatore della scienza moderna, si rendeva conto di quanto poco capisse, e lo espresse magnificamente: “Non so cosa potrei apparire al mondo, ma a me stesso sembra di essere stato solo un ragazzo che giocava sulla riva del mare, e distrarmi di tanto in tanto trovando un ciottolo più liscio o una conchiglia più bella del normale, mentre il grande oceano della verità giaceva tutto inesplorato davanti a me.”
Insegnando ai suoi figli a chiedere e a continuare a chiedere, il giudaismo onorava ciò che Maimonide chiamava “intelletto attivo” e lo vedeva come il dono di Dio. Nessuna fede ha onorato di più l’intelligenza umana.