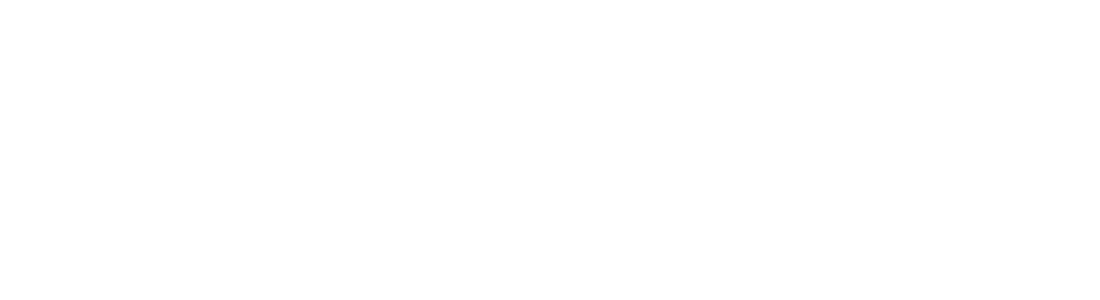Il viaggio ebraico – Parashat Vayishlach
di Rabbino Lord Jonathan Sacks zt”l
tradotto ed adattato da david Malamut
Perché Giacobbe è il padre del nostro popolo, l’eroe della nostra fede? Noi siamo “la congregazione di Giacobbe”, “i figli d’Israele”. Eppure, fu Abramo a dare inizio al viaggio ebraico, Isacco a volersi sacrificare, Giuseppe a salvare la sua famiglia negli anni della carestia, Mosè a condurre il popolo fuori dall’Egitto e a dargli le sue leggi. Fu Giosuè, figlio di Nun, che portò il popolo nella Terra Promessa, Davide che ne divenne il più grande re, Salomone che costruì il Tempio e i profeti nel corso dei secoli che divennero la voce di Dio.
Il racconto di Giacobbe nella Torah sembra non essere all’altezza di queste altre vite, almeno se leggiamo il testo, alla lettera. Ha rapporti tesi con suo fratello Esaù, con le mogli Rachele e Lea, con suo suocero Labano e con i suoi tre figli maggiori, Ruben, Simone e Levi. Ci sono momenti in cui sembra pieno di paura, altri in cui agisce, o almeno sembra agire, con un’onestà tutt’altro che totale. In risposta al Faraone, dice di sé stesso: “E Giacobbe disse a Faraone: Gli anni del mio pellegrinaggio sono cento e trenta. Pochi ed infelici furono gli anni della mia vita, e non giunsero agli anni della vita de’ miei padri nel tempo del loro pellegrinaggio.” (Genesi 47, 9). Questo è meno di quanto potremmo aspettarci dal nostro eroe della fede.
Ecco perché gran parte dell’immagine che abbiamo di Giacobbe è filtrata attraverso la lente del Midrash, ovvero la Tradizione Orale preservata dai Saggi. In questa tradizione, Giacobbe è tutto buono, Esaù tutto cattivo. Doveva essere così, così sosteneva il rabbino Zvi Hirsch Chajes nel suo saggio sulla natura dell’interpretazione midrashica, perché altrimenti difficilmente avremmo tratto dal testo biblico un chiaro senso di giusto e sbagliato, di bene e di male. La Torah è un libro eccezionalmente sottile, e i libri sottili tendono ad essere fraintesi. Quindi, la Tradizione Orale ha reso tutto più semplice: bianco e nero invece di sfumature di grigio.
Eppure, forse, anche senza il Midrash, possiamo trovare una risposta, sarebbe il modo migliore per farlo è pensare all’idea di un viaggio.
L’ebraismo riguarda la fede come un viaggio. Inizia con il viaggio di Abramo e Sara, che lasciano la loro “terra, luogo di nascita e casa paterna” e viaggiano verso una destinazione sconosciuta, “la terra che io ti mostrerò”.
Il popolo ebraico è definito da un altro viaggio in un’epoca diversa: il viaggio di Mosè e degli Israeliti dall’Egitto attraverso il deserto fino alla Terra Promessa. Quel viaggio diventa una litania, una continua lamentela, in Parshat Masè: “Hanno lasciato il posto A e si sono accampati nel posto B. Hanno lasciato il posto B e si sono accampati nel posto C”. Essere ebreo significa spostarsi, viaggiare e solo raramente, se non mai, stabilirsi. Mosè avverte il popolo del pericolo di stabilizzarsi e di dare per scontato lo status quo, anche nello stesso Israele:
<< Quando, procreati figli e nipoti, e divenuti antichi nel paese, avvenga che commettiate gravi colpe, e vi facciate simulacri di qualsiasi figura; facendo così ciò che spiace al Signore, Iddio tuo, e che l’irrita: >> (Deuteronomio 4, 25)
Da qui le regole secondo cui Israele deve sempre ricordare il suo passato, non dimenticare mai i suoi anni di schiavitù in Egitto, non dimenticare mai a Succot che i nostri antenati una volta vivevano in dimore temporanee, non dimenticare mai che non possiede la terra, in quanto appartiene a Dio, e noi siamo semplicemente lì come gerim ve-toshavim di Dio, “forestieri ed avventicci” (stranieri e soggiornanti) (Levitico 25, 23).
Perché così? Perché essere ebreo significa non sentirsi pienamente a casa nel mondo. Essere ebreo significa vivere nella tensione tra cielo e terra, tra creazione e rivelazione, tra il mondo che è e il mondo che siamo chiamati a creare; tra esilio e patria, e tra l’universalità della condizione umana e la particolarità dell’identità ebraica. Gli ebrei non stanno fermi tranne quando stanno davanti a Dio. L’universo, dalle galassie alle particelle subatomiche, è in costante movimento, così come lo è l’anima ebraica.
Siamo, e crediamo di esserlo, una combinazione instabile di polvere della terra e soffio di Dio, e questo ci chiama costantemente a prendere decisioni, scelte, che ci faranno crescere fino a diventare grandi quanto i nostri ideali, o, se scegliamo erroneamente, ci fanno avvizzire in piccole creature petulanti ossessionate dalle banalità. La vita come viaggio significa sforzarsi ogni giorno di essere più grandi di quanto eravamo il giorno prima, individualmente e collettivamente.
Se il concetto di viaggio è una metafora centrale della vita ebraica, qual è a questo proposito la differenza tra Abramo, Isacco e Giacobbe?
La vita di Abramo è incorniciata da due viaggi che usano entrambi la frase Lech lecha,( לֶךְ־לְךָ֛) “intraprendere un viaggio”, una volta in Genesi 12 quando gli fu detto di lasciare la sua terra e la casa paterna, l’altra in Genesi 22, 2 durante la legatura di Isacco, quando gli fu detto: “Prendi tuo figlio, il tuo amato unigenito, Isacco; e vanne [lech lecha] al paese di Morijà”.
Ciò che è così commovente in Abramo è che lui parte immediatamente e senza fare domande, nonostante entrambi i viaggi siano strazianti in termini umani. Nella prima deve lasciare suo padre. Nella seconda deve lasciare andare suo figlio. Deve dire addio al passato e rischiare di dire addio al futuro. Abramo è pura fede. Ama Dio e ha assoluta fiducia in Lui. Non tutti possono raggiungere questo tipo di fede. È quasi sovrumano.
Isacco è esattamente l’opposto. È come se Abramo, conoscendo i sacrifici emotivi che ha dovuto fare, conoscendo anche il trauma che Isacco deve aver provato durante la Legatura, cercasse di proteggere suo figlio per quanto è nel suo potere di farlo. Si assicura che Isacco non lasci la Terra Santa (vedessi Genesi 24, 6 “Ed Abramo gli disse: Bada bene di non far che mio figlio torni colà.”, ecco perché Abramo non gli permette di viaggiare lui stesso per trovare moglie). L’unico viaggio di Isacco (nella terra dei Filistei, in Genesi 26) è limitato e locale. La vita di Isacco è una breve tregua dall’esistenza nomade sperimentata da Abramo e Giacobbe.
Giacobbe è di nuovo diverso. Ciò che lo rende unico è che gli incontri più intensi con Dio, che sono pure i più drammatici di tutto il libro della Genesi, li vive nel bel mezzo del viaggio, da solo, di notte, lontano da casa, in fuga da un pericolo all’altro, da Esaù a Labano nel viaggio di andata, da Labano a Esaù nel ritorno a casa.
Nel mezzo del primo ha la sfolgorante epifania della scala che va dalla terra al cielo, con gli angeli che salgono e scendono, spingendolo a dire al risveglio: “Giacobbe svegliatosi dal suo sonno, disse: C’è dunque il Signore [la divina Provvidenza, anche] in questo luogo, ed io nol sapeva [e pareami sventura dover qui pernottare]. Egli temette, e disse: Oh com’è venerando questo luogo! Questo, non v’ha dubbio, è una Casa di Dio; questa è anzi la porta del cielo.” (Genesi 28, 16-17). Nessuno degli altri patriarchi, nemmeno Mosè, ha una visione simile a questa.
Nella seconda, nella nostra Parasha, ha l’inquietante ed enigmatico incontro di lotta con l’uomo/angelo/Dio, che lo lascia zoppicante ma permanentemente trasformato, l’unica persona nella Torah a ricevere da Dio un nome completamente nuovo, Israele,
“וַיֹּ֗אמֶר לֹ֤א יַעֲקֹב֙ יֵאָמֵ֥ר עוֹד֙ שִׁמְךָ֔ כִּ֖י אִם־יִשְׂרָאֵ֑ל כִּֽי־שָׂרִ֧יתָ עִם־אֱלֹהִ֛ים וְעִם־אֲנָשִׁ֖ים וַתּוּכָֽל׃”
che può significare “uno che ha lottato con Dio e con l’uomo” o “uno che è diventato un principe [sar] davanti a Dio“. (Genesi 32, 28)
L’angelo poi cambiò il suo nome in Israele (Yisrael יִשְׂרָאֵל) perché aveva lottato (sariah שָׂרָה) con Dio e con gli uomini, e aveva vinto. Il nome di Israele deriva da due parole ebraiche: strive (sar, שר) e Dio (El אל). Poiché la parola sar significa anche principe, c’è una connotazione di potere principesco. In questo senso, Israele può significare anche Principe con/dinanzi Dio.
Ciò che è affascinante, è che gli incontri di Giacobbe con gli angeli sono descritti dallo stesso verbo- פגע’ -‘p-g-‘a, (Genesi 28, 11 וַיִּפְגַּ֨ע בַּמָּק֜וֹם וַיָּ֤לֶן שָׁם֙ כִּי־בָ֣א הַשֶּׁ֔מֶשׁ “In un luogo ove s’abbattè, ivi pernottò, essendo tramontato il sole.” e Genesi 32, 2 וְיַעֲקֹ֖ב הָלַ֣ךְ לְדַרְכּ֑וֹ וַיִּפְגְּעוּ־ב֖וֹ מַלְאֲכֵ֥י אֱלֹהִֽים׃“Giacobbe poi seguì il suo viaggio ed incontrò angeli di Dio.”) che significa “un incontro casuale“, come se loro colsero Giacobbe di sorpresa, cosa che chiaramente fecero. I momenti più spirituali di Giacobbe sono quelli che non aveva pianificato. Stava pensando ad altro, a ciò che si stava lasciando alle spalle e a ciò che lo aspettava. Era, per così dire, “sorpreso da Dio”.
Giacobbe è qualcuno con cui possiamo identificarci. Non tutti possono aspirare alla fede amorevole e alla fiducia totale di un Abramo, o alla solitudine di un Isacco. Ma Giacobbe è qualcuno che capiamo. Possiamo sentire la sua paura, comprendere il suo dolore per le tensioni nella sua famiglia e simpatizzare con il suo profondo desiderio di una vita di quiete e pace (i Saggi dicono delle parole di apertura della Parasha della prossima settimana וַיֵּ֣שֶׁב יַעֲקֹ֔ב che “Giacobbe desiderava vivere in pace, ma fu subito gettato nei guai di Giuseppe”).
Il punto non è solo che Giacobbe è il più umano dei patriarchi, ma piuttosto che nel profondo della sua disperazione viene elevato alle più alte vette della spiritualità. È l’uomo che incontra gli angeli. È la persona sorpresa da Dio. È lui che, proprio nei momenti in cui si sente più solo, scopre di non essere solo, che Dio è con lui, che è accompagnato dagli angeli.
Il messaggio di Giacobbe definisce l’esistenza ebraica. Il nostro destino è viaggiare. Noi siamo le persone irrequiete. Rari e brevi sono stati i nostri intermezzi di pace. Ma nel buio della notte ci siamo trovati sollevati da una forza di fede che non sapevamo di avere, circondati da angeli che non sapevamo fossero lì. Se camminiamo sulla via di Giacobbe, anche noi potremmo ritrovarci “sorpresi” da Dio.