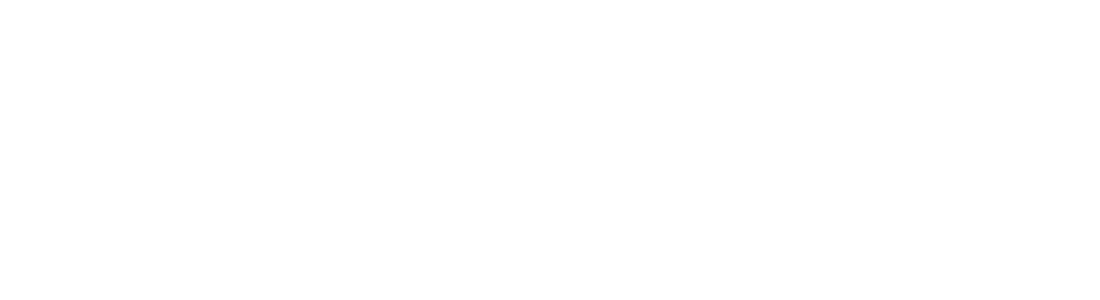Il consiglio comunale di Verona dedica una seduta aperta al Giorno della Memoria
Per la prima volta una seduta aperta del consiglio comunale di Verona è stata dedicata al Giorno della Memoria. Il momento di riflessione e di approfondimento è stato promosso dall’amministrazione in occasione dell’80esimo anniversario della liberazione del campo di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau.
La seduta di ieri, 30 gennaio, ha ospitato gli interventi di Roberto Israel, consigliere nazionale e coordinatore delle attività di Verona dell’associazione Figli della Shoah e in rappresentanza della Comunità Ebraica; di Diomira Pertini, presidente dell’Aned di Verona (associazione nazionale Ex deportati nei campi nazisti); di Luca Fontana, presidente di Assoarma Verona; e di Renato Camurri, professore ordinario di storia contemporanea dell’università di Verona.
Ad aprire il consiglio è stato l’assessore alla memoria storica Jacopo Buffolo, che ha illustrato all’aula il valore della memoria e l’importanza della sua conservazione. «Dedicare un consiglio comunale al Giorno della Memoria, a 80 anni dalla liberazione del campo di concentramento di Auschwitz e a 25 anni dalla sua istituzione è un compito di cui sento tutta la responsabilità – ha spiegato Buffolo – La Verona del 30 gennaio 1945 era una città molto diversa da oggi, ma già aveva la sua centralità ferroviaria che le ha riservato un sinistro ruolo nelle persecuzioni ebraiche e nelle deportazioni politiche e militari. La Verona del 1945 era una città di prigioni e persecuzioni, le cui responsabilità non sono relegabili agli organizzatori della macchina di sterminio nazifascista, ma si estendono anche ai tanti che non intervennero e a chi collaborò con denunce e delazioni. Per questo celebrare il Giorno della Memoria oggi non si può scindere dalla necessità di essere vigili, di non voltarci dall’altra parte quando siamo di fronte a intolleranza, razzismo e discriminazioni di ogni sorta».
Tutti gli interventi degli ospiti sono sono stati di grande interesse ed intense le testimonianze di Pertini e Fontana. La lectio del Prof. Renato Camurri ha toccato argomenti di straordinaria attualità fornendo spunti di profonda riflessione.
Il video completo della seduta è visibile a questo link.
Riportiamo qui di seguito l’intervento integrale di Roberto Israel delegato dalla Presidente Anna Kaufman a rappresentare la Comunità Ebraica .
LA SECONDA GUERRA MONDIALE È LA SHOAH?
Troppo spesso si credere che la Shoah sia iniziata e terminata con la Seconda Guerra mondiale.
Si identifica la Shoah con il periodo 1943-1945, quando la Germania entra fisicamente e politicamente in Italia.
Tutto questo non è vero. Basti solo pensare alla promulgazione delle “leggi razziste”, emanate in Germania nel 1935 ed in Italia nel 1938, ben prima dello scoppio della Seconda Guerra mondiale.
Il trattato di “Diritto dei conflitti armati” che ha origini medioevali (1600) afferma che un conflitto non doveva essere più considerato come “espressione di una giustizia divina”, ma come “il frutto della ragione umana”.
La guerra non è “una relazione tra un uomo ed un altro uomo”, ma una “relazione tra Stati”, dove gli uomini erano solo nemici per caso. I contendenti, una volta deposte le armi, cessano di essere nemici e devono rispettare la loro dignità umana.
Il “Diritto dei conflitti armati” si basa su tre principi: – Distinzione
– necessità militare
– causa di sofferenze inutili
In caso di guerra, l’unico scopo legittimo che gli Stati devono perseguire è quello di indebolire le forze armate del nemico, evitando di aggravare inutilmente le sofferenze di categorie a rischio come quelle dei feriti o dei prigionieri.
Le regole che identificano una guerra convenzionale sono:
a) esistenza di due parti avverse (nemici)
b) impiego di eserciti distinti individuabili da uniformi e bandiere differenti
c) motivazioni di carattere territoriale o ideologico contestate alla parte opposta
d) utilizzo di armi di distruzione o di offesa da una parte e difesa dall’altra
e) istituzioni di campi di concentramento per prigioni, nemici o oppositori ideologici con il fine di estorcere, con metodi più o meno consentiti, informazioni o per persuadere al cambiamento d’opinione.
Alla conclusione di una guerra il vincitore ottiene, secondo un trattato di pace, un risarcimento dei danni subiti.
La Shoah non rispecchia nessuno di questi punti in particolare, nei trattati di pace del 1946 a Parigi, non compariva nessun soggetto che identificasse il Popolo Ebraico o il Popolo Sinto.
Un campo di sterminio non è assimilabile ad un campo di concentramento. Il campo di sterminio, ideato prima dello scoppio della guerra ed utilizzato fino alla totale distruzione della Germania, è un elemento del tutto unico che identifica uno degli aspetti più cruenti della Shoah.
Anche L’Italia ha partecipato in modo attivo a praticare l’eliminazione/stermino di una parte dell’umanità, perché considerata “inutile e dannosa”. Questa responsabilità oggettiva non è mai stata sancita e riconosciuta da nessuna parte.
La Shoah rappresenta l’esempio più estremo dell’antisemitismo. Con questo termine si vuole esprime il pregiudizio e l’odio nei confronti del popolo ebraico. Nel diciottesimo e diciannovesimo secolo a livello europeo si nutriva un odio/diffidenza per ogni ebreo in qualsiasi ambito.
Fra le azioni antisemite più violente ricordiamo i pogrom, violente sommosse popolari, spesso con l’appoggio delle autorità locali, le quali diffondevano campagne false e diffamatorie nei confronti degli ebrei al fine di sollevare massacri da parte della popolazione, ad esempio, i Protocolli dei Savi di Sion.
I nazisti ed i fascisti spingono il popolo a scatenare la violenza sui loro “vicini” ebrei, ad appropriarsi dei loro beni, a sostituirsi nelle loro case ed occupazioni. Arrivando ad un livello di partecipazione così allargato da dover essere ignorato nei manuali di storia che accompagnano il ritorno alla normalità.
Uno degli elementi più rilevanti dello sterminio nei territori dell’Europa orientale è dato dalla sua “esplicita natura pubblica”. Le vittime furono trucidate a colpi d’arma da fuoco dopo essere state prelevate alla presenza dei concittadini e avviate a piedi verso il luogo dell’esecuzione.
Ancora oggi spesso il senso comune associa la “soluzione finale” solo ai campi di sterminio nazisti, portato a restringere la problematica a una relazione unica tra esecutori, i tedeschi, e vittime, gli ebrei.
Da questa relazione duale, è emerso con forza un elemento più complesso: la “complicità” delle popolazioni locali nello sterminio, una complicità su cui il dispositivo politico e storiografico aveva fatto calare il silenzio nell’immediato dopoguerra.
A maggior ragione la Shoah si differenzia dalla seconda guerra mondiale se consideriamo che immediatamente dopo pochi giorni, subito dopo la ritirata
dell’Armata rossa, negli stati che subirono l’invasione tedesca, in Lituania, Lettonia, Ucraina occidentale, Polonia orientale (ch’era stata occupata dall’Unione Sovietica) , Bielorussia e nella Russia centrale, scoppiarono dei pogrom spontanei.
L’assassinio degli ebrei e il saccheggio delle loro proprietà avvennero prima ancora dell’intervento degli Einsatzgruppen e senza alcun concorso delle truppe della Wehrmacht, per opera di connazionali cristiani.
Inoltre, con la conclusione della Seconda guerra mondiale, di fatto la Shoah non si concluse, ma continuò nello stesso modo o con modalità differenti.
Basti ricordare il 4 luglio 1946 a Kielce, cittadina polacca, in cui avvenne il massacro totale dei sopravvissuti della comunità ebraica da parte della popolazione locale non più sotto il controllo dei Nazisti.
La rapidità e la brutalità con cui si scatenò dà una prova inconfutabile della separazione fra la guerra e la Shoah. Per gli ebrei sopravvissuti nei Paesi comunisti riprende l’antisemitismo già presente a partire dalla metà fine dell’800.
Immediatamente dopo la fine della guerra i sopravvissuti ai campi di sterminio rappresentarono per i vincitori un problema. Furono istituiti campi di concentramento, certamente non di sterminio, per decidere, senza alcun piano, dove “mettere” questa gente.
La permanenza in questi nuovi campi non fu di qualche giorno o mese ma si arrivò fino al 1952.
Le possibilità di emigrare legalmente negli Stati Uniti erano poche. Gli Inglesi, si dimostrarono restii ad accogliere i sopravvissuti, limitarono fortemente l’immigrazione in Palestina, in cui avevano la sovranità e così molte nazioni europee rimasero chiuse ai profughi in cerca di una nuova casa.
Non era un problema di carattere logistico, ma specialmente una difficoltà politica e sociale.
Oggi sembra strano, ma la shoah esiste ancora, soprattutto nelle varie forme di negazionismo o banalizzazione dei fatti accaduti, paragonando qualsiasi situazione negativa alla stregua della shoah.
Ogni massacro o simili atrocità è un evento abominevole, ma proprio per questo non va banalizzato associandolo ad altri fatti. Ogni fatto va affrontato nella sua esclusiva situazione, altrimenti si rischia di dimenticarlo o addirittura di renderlo un fatto normale.
L’antisemitismo non è scomparso, ma si nasconde sotto diverse sfaccettature, la più eclatante è l’anti israelianismo, dove si accusa in ogni occasione di qualsiasi responsabilità mondiale lo Stato d’Israele, senza mai prendere in considerazione che è uno stato democratico con tutti i suoi pregi e difetti tali e quali a qualsiasi altro stato democratico primo fra tutti L’Italia stessa.
Le accuse rivolte verso lo Stato d’Israele realmente racchiudono lo storico pregiudizio e odio verso gli ebrei che esplode nei social con auguri di morte a Liliana Segre presidente onorario della Associazione figli della shoah.
Roberto Israel
Associazione figli della Shoah sez. Verona