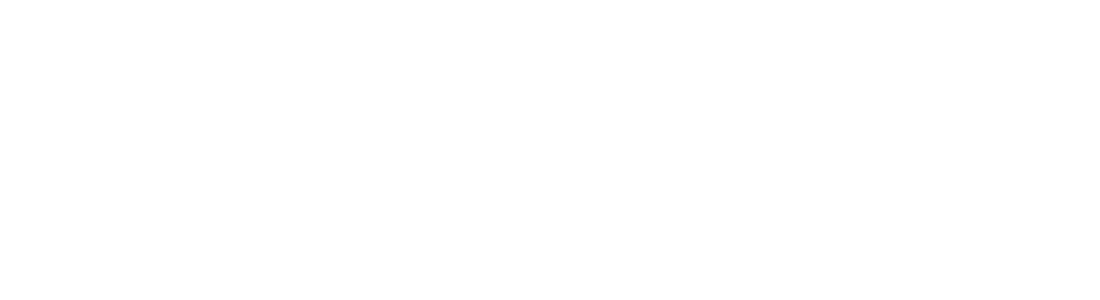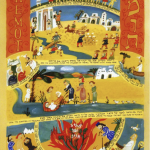Chi sono io? – Parashat Shemot
di Rabbino Lord Jonathan Sacks zt”l
tradotto ed adattato da David Malamut
La seconda domanda di Mosè a Dio verso al Roveto Ardente fu: “Chi sei?“. Lui chiede il Signore nel modo seguente:
<<Mosè disse a Dio: Ecco io vado ai figli d’Israel, e dico loro: Il Dio de’ vostri padri mi mandò a voi; se mi dicono: Qual è il suo nome? che cosa ho da dir loro?>> (Esodo 3,13)
La risposta di Dio, Ehyeh asher ehyeh אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה tradotta erroneamente in quasi ogni Bibbia cristiana come qualcosa come “Io sono colui che sono”, merita un tema a sé stante.
La prima domanda di Mosè, però, fu Mi anochi: מִי אָנֹכִי “Chi sono io?”
<<Mosè disse a Dio: Chi son io, che possa andare da Faraone, e trarre i figli d’Israel dall’Egitto?>> (Esodo 3,11)
Apparentemente, il significato è abbastanza chiaro. Mosè chiede due cose. La prima: chi sono io, per essere degno di una missione così grande? La seconda: come posso riuscirci?
Dio risponde alla seconda. “Perché sarò con te.” Avrai successo perché non ti sto chiedendo di farlo da solo. In realtà non ti sto chiedendo affatto di farlo. Lo farò per te. Voglio che tu sia il Mio rappresentante, il Mio portavoce, il Mio emissario e la Mia voce.
Dio non ha mai risposto alla prima domanda. Forse, in modo strano Mosè si è risposto da solo. Nel Tanach nel suo insieme, le persone che risultano essere le più degne sono quelle che negano del tutto di esserlo. Il profeta Isaia, quando fu incaricato della sua missione, disse: “conciossiachè io sia uomo immondo di labbra” (Isaia 6,5). Geremia disse: “Ecco io non so concionare; impercioccè son giovine” (Geremia 1,6). Davide, il più grande re d’Israele, fece eco alle parole di Mosè: “Chi sono io?” (Samuele II 7,18). Giona, inviato in missione da Dio, cercò di scappare. Secondo Rashbam (Rav Samuel ben Meir, Francia 1085-1158), Giacobbe stava per scappare quando si trovò la strada bloccata dall’uomo/angelo con cui lottava di notte (Rashbam su Genesi 32,23).
Gli eroi della Bibbia non sono figure della mitologia greca, romana o di qualsiasi altro tipo di mito. Non sono persone dotate del senso del destino, determinate fin dalla tenera età a raggiungere la fama. Non hanno ciò che i greci chiamavano megalopsychia (in italiano magnanimità), un giusto senso del proprio valore, una superiorità graziosa e leggermente logora. Non andarono di certo a studiare a Eton o a Oxford, note Università britanniche di prestigio mondiale. Non sono nati per governare. Erano invece persone che dubitavano delle proprie capacità, che diventavano eroi della vita morale contro la loro volontà. C’erano momenti in cui avevano voglia di arrendersi. Mosè, Elia, Geremia e Giona raggiunsero punti di tale disperazione che pregarono di morire. Ma c’era del lavoro da fare, e Dio glieli aveva detto, e lo fecero. È quasi come se il senso di piccolezza fosse un segno di grandezza. Quindi, Dio non ha mai risposto alla domanda di Mosè: “Perché proprio a me?” ma col tempo la risposta si è rivelata.
Tuttavia, c’è un’altra domanda nella domanda. “Chi sono io?” non può essere solo una questione di dignità. Può anche essere una questione di identità. Mosè, essendo da solo sul monte, chiamato da Dio per condurre gli Israeliti fuori dall’Egitto, non sta semplicemente parlando a Dio quando pronuncia quelle parole. Sta parlando anche a sé stesso. “Chi sono io?”
Ci sono due possibili risposte. La prima: Mosè è un principe d’Egitto. Era stato adottato da bambino dalla figlia del faraone. Era cresciuto nel palazzo reale. Si vestiva come un egiziano, sembrava e parlava come un egiziano. Quando salvò le figlie di Ietro (Ytro) da alcuni rozzi pastori, tornarono a casa e dissero al padre: ” Un uomo egizio ci liberò dai pastori, ” (Esodo 2,19). Il suo stesso nome, Mosè, gli fu dato dalla figlia del Faraone (Esodo 2,10). Si trattava, presumibilmente, di un nome egiziano (infatti, ‘Mosè‘, come in ‘Ramses‘, è l’antica parola egiziana per ”bambino“. L’etimologia data nella Torah, che Mosè significa “Lo trassi dall’acqua” ci dice quanto fosse suggestiva la parola stessa per gli ebrei). Quindi la prima risposta è che Mosè era un principe egiziano.
La seconda, che era un madianita. Infatti, sebbene fosse egiziano di educazione, era stato costretto ad andarsene. Si era stabilito a Madian, aveva sposato una donna madianita, Tzipporah, figlia di un sacerdote madianita, ed era stato “contento di vivere” lì, tranquillamente come pastore. Tendiamo a dimenticare quanti anni ha trascorso lì. Lasciò l’Egitto da giovane e aveva già ottant’anni all’inizio della sua missione quando si presentò per la prima volta davanti al Faraone (Esodo 7,7). Deve aver trascorso la stragrande maggioranza della sua vita adulta a Madian, lontano dagli israeliti da un lato e dagli egiziani dall’altro. Mosè era un madianita.
Quindi, quando Mosè chiede: “Chi sono io?” non è solo che si sente indegno. Si sente estraneo. Potrebbe essere stato ebreo di nascita, ma non aveva subito il destino del suo popolo. Non era cresciuto come ebreo. Non aveva vissuto tra gli ebrei. Aveva buone ragioni per dubitare che gli israeliti lo riconoscessero come uno di loro. Come avrebbe potuto, allora, diventare il loro leader? In modo ancora più toccante, perché dovrebbe anche solo pensare di diventare il loro leader? Il loro destino non era il suo. Non ne faceva parte. Non ne era responsabile. Non ne ha sofferto. Non era implicato in ciò.
Inoltre, l’unica volta che aveva effettivamente tentato di interferire nei loro affari, addirittura uccise un sorvegliante egiziano che aveva ucciso a sua volta uno schiavo israelita, e il giorno successivo cercò di impedire a due israeliti di combattere tra loro, di fatto il suo intervento non fu accolto con favore. “Chi t’ha costituito signore e giudice su di noi?” (Esodo 2,14) gli hanno detto. Queste sono le prime parole registrate di un israelita a Mosè. Non aveva ancora sognato di diventare un leader e già la sua leadership veniva messa in discussione.
Consideriamo ora le scelte che Mosè dovette affrontare nella sua vita. Da un lato avrebbe potuto vivere come un principe d’Egitto, nel lusso e a proprio agio. Questo avrebbe potuto essere il suo destino se non fosse intervenuto. Anche in seguito, essendo stato costretto a fuggire, avrebbe potuto vivere tranquillamente i suoi giorni da pastore, in pace con la famiglia madianita con cui si era sposato. Non sorprende che quando Dio lo invitò a condurre gli Israeliti verso la libertà, egli resistette e si oppose.
Perché allora ha accettato lo stesso? Come faceva Dio a sapere che era lui l’uomo adatto a quel compito? Un indizio è contenuto nel nome che diede al suo primo figlio. Lo chiamò Gershom perché, disse: “Sono divenuto pellegrino in terra straniera.” (Esodo 2,22). Non si sentiva a casa a Madian. Era lì che si trovava fisicamente, ma non chi lo fosse veramente.
Ma il vero indizio è contenuto in un verso precedente, preludio al suo primo intervento. “Ora, in quel tempo, cresciuto Mosè, uscì appo i suoi fratelli, osservò le loro gravezze; vide un uomo egizio, che batteva un uomo ebreo, dei suoi fratelli.” (Esodo 2,11).
Queste persone erano la sua gente. Potrebbe sembrare un egiziano ma sapeva che alla fine non lo era. Fu un momento di trasformazione, non diversamente da quando la moabita Ruth disse alla suocera israelita Naomi: “il tuo popolo sarà il
mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio” (Ruth 1,16). Ruth non era ebrea di nascita. Mosè non era ebreo per educazione. Ma entrambi sapevano che quando vedevano la sofferenza e si identificavano con la sofferenza, non potevano andarsene.
Rav Joseph Soloveitchik lo definì un patto del destino, brit hagoral. Essa costituisce ancora oggi il cuore dell’identità ebraica. Ci sono ebrei che credono e altri che non ci credono. Ci sono ebrei che praticano e altri che non lo fanno. Ma sono davvero pochi gli ebrei che, quando il loro popolo soffre, possono andarsene girando le proprie spalle dicendo: “Questo non ha niente a che fare con me”.
Maimonide, che definisce questo come “separarsi dalla comunità” (poresh mi-darchei ha-tsibbur, Hilchot Teshuva 3,11), dice che è uno dei peccati per i quali ti viene negata una parte nel mondo a venire. Questo è ciò che intende l’Haggadah di Pesach quando dice del figlio malvagio che “poiché si esclude dalla collettività, nega un principio fondamentale della fede”. Quale principio fondamentale della fede? Fede nel destino collettivo e nel destino del popolo ebraico.
Chi sono io? chiese Mosè, ma in cuor suo conosceva già la risposta. Non sono Mosè l’Egiziano o Mosè il Madianita. Quando vedo soffrire il mio popolo, sono e non posso essere altro che Mosè l’ebreo. E se questo mi impone delle responsabilità, allora devo assumermele. Perché io sono quello che sono perché la mia gente è quello che sono. Questa è l’identità ebraica, allora e adesso.