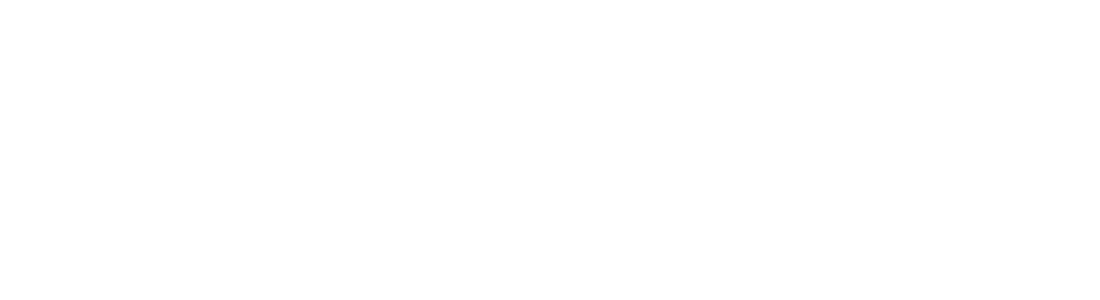Accampamenti e viaggi – Parashat Pekudei
di Rabbino Lord Jonathan Sacks zt”l
tradotto ed adattato da David Malamut
Proprio alla fine del libro di Shemot, c’è una difficoltà testuale così lieve che è facile non notarla, eppure, come interpretato da Rashi, contiene uno dei grandi indizi sulla natura dell’identità ebraica: è una commovente testimonianza della sfida unica di essere ebrei.
Innanzitutto, il contesto. Il Tabernacolo è finalmente completo. La sua costruzione ha richiesto molti capitoli per essere raccontata. Nessun altro evento negli anni del deserto è descritto in modo così dettagliato. Ora, il primo di Nissan, esattamente un anno dopo che Mosè disse al popolo di iniziare i preparativi per l’Esodo, egli assembla le travi e le tende e mette al loro posto i mobili e gli utensili. C’è un inequivocabile parallelismo tra le parole che la Torah usa per descrivere il completamento dell’opera da parte di Mosè e quelle che usa per Dio il settimo giorno della Creazione:
<< Iddio avendo nel giorno settimo terminata l’opera ch’egli fece, cessò nel giorno settimo da tutta l’opera ch’egli avea fatta, Iddio benedisse il giorno settimo, e lo santificò ; poiché in esso cessò da tutta l’opera sua, che Dio avea creata e fatta.>> (Genesi 2, 2-3)
<< … e Mosè terminò [vayechal] l’opera [hamelachah]. >>
וַיְכַ֥ל מֹשֶׁ֖ה אֶת־הַמְּלָאכָֽה (Esodo 40, 33)
Il verso successivo nella nostra parsha, Pekudei, afferma il risultato:
<<Allora la nube coperse il padiglione di congregazione, e la Maestà del Signore empì il tabernacolo.>> (Esodo 40, 3
Il significato è sia chiaro che rivoluzionario. La creazione del Santuario da parte degli Israeliti intende rappresentare un parallelo umano alla creazione divina dell’universo. Nel creare il mondo, Dio ha creato una casa per l’umanità. Nel creare il Tabernacolo, l’umanità ha creato una casa per Dio.
Da una prospettiva umana, Dio riempie lo spazio che creiamo per la Sua presenza. La Sua gloria esiste dove rinunciamo alla nostra. L’immenso dettaglio della costruzione è lì per dirci che, in tutto questo, gli Israeliti obbedivano alle istruzioni di Dio piuttosto che improvvisare le proprie. Il dominio specifico chiamato “il sacro” è dove incontriamo Dio alle Sue condizioni, non alle nostre. Eppure, anche questo è il modo di Dio di conferire dignità all’umanità. Siamo noi che costruiamo la Sua casa affinché Egli possa riempire ciò che abbiamo creato. Nelle parole di un famoso film (Field of Dreams– L’uomo dei sogni, del 1989 con Kevin Costner): “Se lo costruisci, lui verrà”.
Bereishit, Genesi, inizia con Dio che crea il cosmo. Shemot, Esodo, termina con gli esseri umani che creano un microcosmo, un universo in miniatura e simbolico. Quindi l’intera narrazione di Genesi-Esodo è un unico vasto arco che inizia e finisce con il concetto di spazio pieno di Dio, con questa differenza: che all’inizio l’opera è fatta da Dio-il-Creatore. Alla fine, è fatta dall’uomo-e-dalla-donna-i-creatori. L’intera storia intricata è stata una storia con un tema dominante: il trasferimento del potere e della responsabilità della creazione dal cielo alla terra, da Dio all’immagine-di-Dio chiamata umanità.
Questo è il contesto. Tuttavia, gli ultimi versetti del libro continuano a raccontarci della relazione tra la “Nuvola di Gloria” e il Tabernacolo. Il Tabernacolo, ricordiamo, non era una struttura fissa. Era fatto in modo tale da essere portatile. Poteva essere rapidamente smontato e le sue parti trasportate, mentre gli Israeliti si dirigevano verso la fase successiva del loro viaggio. Quando giunse il momento per gli Israeliti di proseguire, la Nuvola si spostò dal suo luogo di riposo nella Tenda del Convegno a una posizione esterna all’accampamento, segnalando la direzione che dovevano prendere. Ecco come la Torah lo descrive:
<<E quando la nube si scostava d’in sul tabernacolo, gl’Israeliti movevansi, in tutt’i loro viaggi. E se quella non si scostava, non movevansi, (e attendevano) sino al
giorno che si scostasse. Poiché la nube del Signore era sul tabernacolo durante il giorno, e durante la notte eravi fuoco dentro di essa (nube); (e ciò era) alla vista di tutta la casa d’Israel, in tutt’i loro viaggi. >> (Esodo 40, 36-38)
C’è una piccola ma significativa differenza tra i due casi della frase bechol mas’ehem, “in tutti i loro viaggi“. Nel primo caso le parole devono essere prese alla lettera. Quando la Nuvola si sollevò e andò avanti, gli Israeliti sapevano che stavano per viaggiare.
Tuttavia, nel secondo caso non possono essere prese alla lettera. La Nuvola non era sopra il Tabernacolo in tutti i loro viaggi. Al contrario: era lì solo quando smettevano di viaggiare e invece piantavano l’accampamento. Durante i viaggi, la Nuvola andava avanti.
Notando questo, Rashi fa il seguente commento:
“Un luogo dove si accamparono è anche chiamato massa, “un viaggio” … Poiché dal luogo dell’accampamento ripartirono sempre per un nuovo viaggio, perciò sono tutti chiamati “viaggi”.” (commenti di Rashi su Esodo 40, 38)
Il punto è linguistico, ma il messaggio è tutt’altro. Rashi ha condensato in poche parole, “un luogo in cui si sono accampati è anche chiamato un viaggio”, la verità esistenziale al centro dell’identità ebraica. Finché non abbiamo ancora raggiunto la nostra destinazione, anche un luogo di riposo è ancora chiamato un viaggio, perché sappiamo che non siamo qui per sempre. C’è ancora una strada da percorrere.
Nelle parole del poeta Robert Frost:
“I boschi sono incantevoli, scuri e profondi.
Ma ho delle promesse da mantenere,
E miglia da percorrere prima di dormire.”
(“Fermata nei boschi in una sera di neve“, in The Poetry of Robert Frost)
Essere ebrei significa viaggiare e sapere che qui dove siamo è un semplice luogo di riposo, non ancora una casa. Non è definito dal fatto che siamo qui, ma dalla consapevolezza che alla fine, dopo un giorno, una settimana, un anno, un secolo, a volte persino un millennio, dovremo andare avanti. Così, il Tabernacolo portatile, ancora più del Tempio di Gerusalemme, divenne il simbolo della vita ebraica.
Perché? Perché gli dèi del mondo antico erano dei di un luogo: Sumeria, Menfi, Moab, Edom. Avevano un dominio specifico. La teologia era legata alla geografia. Qui, in questo luogo sacro, reso magnifico da ziggurat o tempio, gli dèi della tribù o dello stato governavano ed esercitavano il potere sulla città o sull’impero. Quando il faraone dice a Mosè: “…Chi è egli il Signore, ch’io abbia ad ubbidirgli di lasciar andare Israel? Non conosco il Signore, nè voglio lasciar andare Israel” (Esodo 5, 2), intende dire: “Ecco, io sono il potere sovrano. L’Egitto ha i suoi dèi. Entro i suoi confini, solo loro governano e hanno delegato quel potere a me, il loro rappresentante terreno. Può effettivamente esserci un Dio di Israele, ma il suo potere e la sua autorità non si estendono all’Egitto“. La sovranità divina è come la sovranità politica. Ha confini. Ha una posizione spaziale. È delimitata da un luogo sulla mappa.
Con Israele, rinasce un’idea vecchia-nuova (che risale, secondo la Torah, a Adamo, Caino, Abramo e Giacobbe, tutti e tre esiliati): che Dio, essendo ovunque, può essere trovato ovunque. Egli è ciò che Morris Berman chiama il “Dio errante” (Morris Berman, Wandering God: A Study in Nomadic Spirituality). Proprio come nel deserto la Sua Nuvola di Gloria accompagnò gli Israeliti nel loro lungo e tortuoso viaggio, così, dissero i rabbini, “quando Israele andò in esilio, la Presenza Divina andò con loro” (Talmud Babilonese, trattato di Megilla 29a; Sifrei, Numbers, p. 161). Dio non può essere confinato in un luogo specifico. Anche in Israele, la Sua presenza tra il popolo dipendeva dalla loro obbedienza alla Sua parola. Quindi non esiste una cosa come la sicurezza fisica, la conoscenza certa che eccomi e qui resto. Come disse David, nei Salmi:
<<Signore, io ti esalterò; perciocchè tu mi hai tratto ad alto, e non hai rallegrati di me i miei nemici. Signore Iddio mio, io ho gridato a te, e tu mi hai sanato. Signore, tu hai fatta salir l’anima mia fuor del sepolcro; tu mi hai salvata la vita, acciocchè io non iscendessi nella fossa. Salmeggiate al Signore voi suoi santi; e celebrate la memoria della sua santità. Perciocchè l’ira sua dura solo un momento; ma la sua benevolenza >> (Salmo 30)
La sicurezza non appartiene al luogo ma alla persona, non a uno spazio fisico sulla superficie della terra ma a uno spazio spirituale nel cuore umano.
Se c’è qualcosa che è responsabile della forza senza pari dell’identità ebraica durante i lunghi secoli in cui gli ebrei erano sparsi in tutto il mondo, una minoranza, è il concetto a cui gli ebrei e l’ebraismo hanno dato il nome di galut, esilio. Unici tra le nazioni nel mondo antico o moderno, con poche eccezioni non si convertirono alla fede dominante né si assimilarono alla cultura prevalente. L’unica ragione era che non scambiarono mai un luogo particolare per casa, una posizione temporanea per la destinazione finale. “Ora siamo qui“, dissero all’inizio del servizio del Seder di Pesach, “ma l’anno prossimo, nella terra di Israele“.
Nella legge ebraica, chi affitta una casa fuori Israele è obbligato ad apporre una mezuza solo dopo trenta giorni (Shulchan Aruch, Yoreh De’ah 286, 22). Fino a quel momento non è ancora considerata un luogo di dimora. Solo dopo trenta giorni diventa, di fatto, casa. In Israele, tuttavia, chi affitta una casa è immediatamente obbligato, mishum yishuv Eretz Yisrael, “a causa della mitzvah di stabilirsi in Israele“. Fuori Israele, la vita ebraica è una via, un sentiero, una rotta. Anche un accampamento, un luogo di riposo, è ancora chiamato un viaggio.
In questo contesto, un dettaglio spicca nella lunga lista di istruzioni sul Tabernacolo. Riguarda l’Arca, in cui erano conservate le Tavole di pietra che Mosè portò giù dalla montagna, come promemoria permanenti del patto di Dio con Israele. Su un lato dell’Arca c’erano anelli d’oro, due su ogni lato, all’interno dei quali venivano posizionate delle aste o stanghe in modo che l’Arca potesse essere trasportata quando fosse giunto il momento per gli Israeliti di proseguire (Esodo 25, 12-14). La Torah aggiunge la seguente clausola:
<<Nelle anella dell’arca staranno le stanghe, non debbono esserne rimosse.>> (Esodo 25, 15)
Perché? Il rabbino Samson Raphael Hirsch spiegò che l’Arca doveva essere sempre pronta quando fosse sorta la necessità per gli Israeliti di viaggiare. Perché lo stesso non era vero per gli altri oggetti nel Tabernacolo, come l’altare e la menorah? Per dimostrare in modo supremo, disse Hirsch, che la Torah non era limitata a un solo luogo (Il Pentateuco, tradotto con commenti by Samson Raphael Hirsch). E così fu. La Torah divenne, nella famosa frase di Heinrich Heine, “la patria portatile dell’ebreo“. Nel corso della storia gli ebrei si ritrovarono sparsi e dispersi tra le nazioni, senza mai sapere quando sarebbero stati costretti ad andarsene e a trovare una nuova casa. Solo nel XV secolo, gli ebrei furono espulsi da Vienna e Linz nel 1421, da Colonia nel 1424, da Augusta nel 1439, dalla Baviera nel 1442, dalla Moravia nel 1454, da Perugia nel 1485, da Vicenza nel 1486, da Parma nel 1488, da Milano e Lucca nel 1489, dalla Spagna nel 1492 e dal Portogallo nel 1497 (Paul Johnson, A History of the Jews).
Come sopravvissero, con la loro identità intatta, la loro fede, sebbene duramente messa alla prova, ancora forte? Perché credevano che Dio fosse con loro, persino in esilio. Perché erano sostenuti dal verso dei Salmi (Salmo 23, 4), “Anche se cammino nella valle dell’ombra della morte, non temerò alcun male, perché Tu sei con me“. Perché avevano ancora la Torah, l’infrangibile patto di Dio, con la sua promessa che “Nonostante questo, quando saranno nella terra dei loro nemici, non li rifiuterò né li aborrirò fino a distruggerli completamente, rompendo il mio patto con loro. Io sono il Signore loro Dio” (Levitico 26, 44). Perché erano un popolo abituato a viaggiare, sapendo che persino un accampamento è solo una dimora temporanea.
Emil Fackenheim, il famoso teologo, era un sopravvissuto all’Olocausto. Nato a Halle, in Germania, nel 1916, fu arrestato durante la Kristallnacht e internato nel campo di concentramento di Sachsenhausen, da cui alla fine riuscì a fuggire. Ricordava un quadro appeso nella casa dei suoi genitori quando era bambino:
“Non era il nostro genere di foto… perché ciò che ritraeva non era un’esperienza ebraico-tedesca: ebrei in fuga da un pogrom. Tuttavia, mi commosse profondamente e lo ricordo bene. Gli ebrei in fuga nella foto sono vecchi barbuti, terrorizzati, ma non tanto da lasciare dietro di sé ciò che hanno di più prezioso. Dal punto di vista degli antisemiti, questi ebrei senza dubbio stringerebbero borse d’oro. Infatti, ognuno di loro porta con sé un rotolo della Torah.”
(Emil Fackenheim, Che cos’è l’ebraismo? (New York: Macmillan, 1987), p. 60.)
Non c’è niente nella storia che assomigli a questa capacità ebraica di viaggiare, di andare avanti, accompagnata solo dalla parola divina, dalla promessa, dalla chiamata, dalla fede in una destinazione finale. È così che è iniziata la storia ebraica, con la chiamata di Dio ad Abramo a lasciare la sua terra, il suo luogo di nascita e la casa di suo padre (Genesi 12, 1). È così che la storia ebraica è continuata per la maggior parte dei quattromila anni. Fuori da Israele, l’unica sicurezza degli ebrei era la fede stessa e il suo eterno resoconto nella Torah, la lettera d’amore di Dio al popolo ebraico, il suo legame indissolubile. E durante tutti quei secoli, sebbene fossero derisi come “l’ebreo errante” (Galit Hasan-Rokem and Alan Dundes, The Wandering Jew: Essays in the Interpretation of a Christian Legend), divennero testimonianza vivente della possibilità della fede in mezzo all’incertezza, e del Dio che ha reso possibile questa fede, il Dio di ogni luogo, simboleggiato dal Tabernacolo, la sua casa portatile.
E quando giunse il momento per gli ebrei di fare un altro viaggio, verso la terra promessa per la prima volta ad Abramo e verso la quale Mosè trascorse la sua vita come leader viaggiando, lo fecero senza esitazione o esitazione. Scene di commiato si sono ripetute più e più volte durante gli anni 1948-51, quando una dopo l’altra, le comunità ebraiche nelle terre arabe, Maghreb, Iraq, Yemen, hanno detto addio alle case in cui avevano vissuto per secoli e sono partite per Israele. Anche loro sapevano che quelle case erano solo accampamenti, tappe di un viaggio la cui destinazione finale era altrove.
Nel 1990, il Dalai Lama, che viveva in esilio dal Tibet dal 1951, invitò un gruppo di studiosi ebrei a fargli visita nell’India settentrionale. Rendendosi conto che lui e i suoi seguaci avrebbero potuto dover trascorrere molti anni in esilio prima di poter tornare, aveva riflettuto sulla questione: come può uno stile di vita sostenersi lontano da casa? Si rese conto che un gruppo più di tutti gli altri aveva affrontato e risolto quel problema: gli ebrei. Così si rivolse a loro per un consiglio (Roger Kamenetz, The Jew in the Lotus).
Se la risposta ebraica, che ha a che fare con la fede nel Dio della storia, sia applicabile al buddismo è un punto controverso, ma l’incontro fu comunque affascinante, perché dimostrò che persino il Dalai Lama, leader di un gruppo molto lontano dall’ebraismo, riconobbe che c’è qualcosa di ineguagliabile nella capacità ebraica di rimanere fedele ai termini della sua esistenza nonostante la dispersione, senza mai perdere la fede che un giorno gli esuli sarebbero tornati nella loro terra.
Come e perché ciò accadde è contenuto in quelle semplici parole di Rashi alla fine dell’Esodo. Anche quando erano a riposo, gli ebrei sapevano che un giorno avrebbero dovuto sradicare le loro tende, smantellare il Tabernacolo e andare avanti. “Anche un accampamento è chiamato viaggio“. Un popolo che non smette mai di viaggiare è un popolo che non invecchia mai, non diventa stantio o compiacente. Può vivere nel qui e ora, ma è sempre consapevole del lontano passato e del futuro che ancora lo attrae.
“Ma ho promesse da mantenere
e chilometri da percorrere prima di dormire.”
(“Fermata nei boschi in una sera di neve“, in The Poetry of Robert Frost)